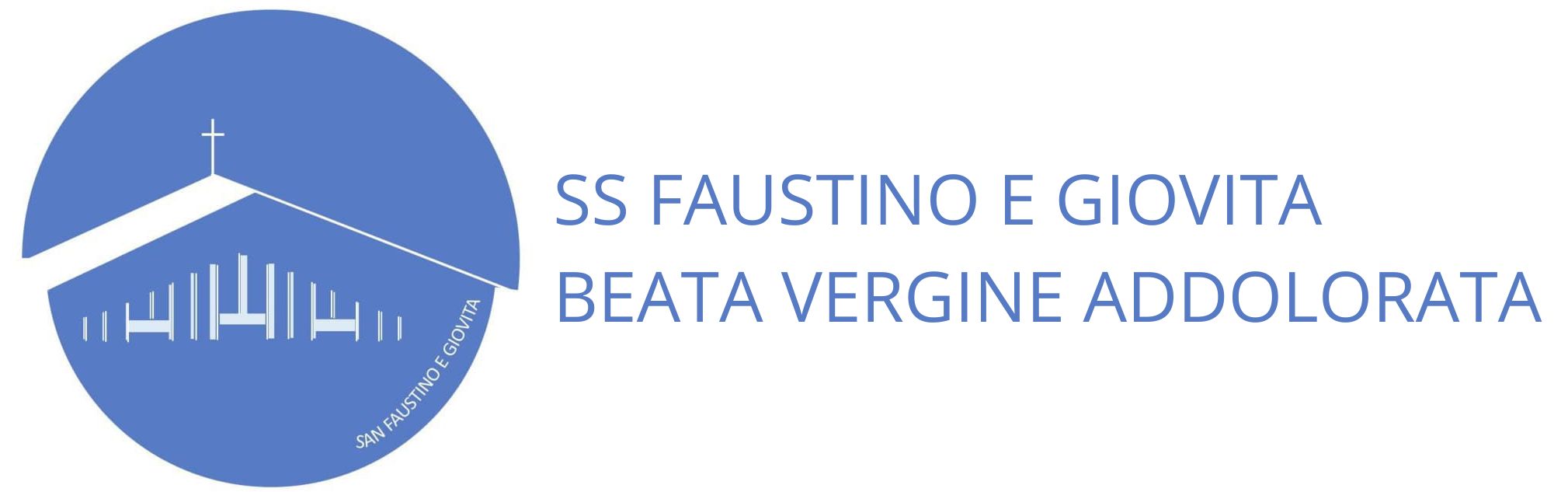In un tempo di guerra occorre il coraggio della pace.
Nel 1955 don Primo Mazzolari pubblica in forma anonima, per evitare provvedimenti ecclesiastici, “Tu non uccidere” la sua tormentata riflessione sulla guerra, maturata nel fuoco dei drammi del Novecento.
Nel muro esterno della chiesa di san Faustino (quella antica come nell’attuale) è incastonata una palla di cannone, indelebile ricordo di un quartiere che nei secoli fu teatro di battaglie e assedi. In questo nostro tempo la guerra è la spina nel fianco dei cristiani che non potranno mai smettere di farsi “costruttori di pace”.
LA PACE COMINCIA DA CIASCUNO, COME LA GUERRA
La pace cristiana non è regolata dal «do ut des»: se tu sarai pacifico con me, io lo sarò con te.
Il cristiano procede per altra strada e dietro altra logica: «Udiste che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico” . Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e manda la pioggia ai giusti e agli iniqui. Perché, se amate quelli che vi amano, qual merito avete? Non fanno lo stesso i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate da più degli altri? Non usano lo stesso i gentili? Siate dunque perfetti com’è perfetto il vostro Padre celeste» (Matteo 5,43-48).
Un cristiano deve fare la pace anche quando venissero meno «le ragioni di pace».
Al pari della fede, della speranza e della carità, la pace è vera beatitudine quando non c’è tornaconto né convenienza né interesse di pace, vale a dire quando incomincia a parere una follia davanti al buon senso della gente «ragionevole».
Se uno raccorcia la pace, o cerca di contenerla nell’area di una «ragione computistica», sarà portato a concludere che il non essere in pace con chi non è in pace con noi, non è un peccato, ma un diritto che arriva fino allo sterminio della parte avversa.
La contabilità cristiana conosce la sola partita del dare: se vi aggiungiamo l’avere, non ci dobbiamo sorprendere se rivedremo sul tappeto le ragioni del lupo, il quale, essendo a monte del fiume, trovava che l’agnello gli intorbidiva le acque.
Se gli altri odiano, non è una ragione perché odiamo anche noi. Si vince il male col bene; la malattia con la salute; si oppone all’ostilità la carità: questo è il comandamento di Dio. Gli altri sono comandamenti di uomini, e uomini senza Dio, anche se fanno salamelecchi al prete.
Quando ci si giustifica delle ingiurie nostre col fatto delle ingiurie altrui, decadiamo dal cristianesimo: rendiamo nulla l’incarnazione con la passione e la risurrezione di Cristo.
Ad amare i soli amici erano buoni anche i pagani.
La pace comincia in noi… in me e da me, da te, da ciascuno… Come la guerra.
Ma come si può arrivare alla pace se si seguita a coltivare, quasi orto per ortaggi, questa spartizione manichea dell’umanità e della spiritualità; se si seguita ad alimentare una polemica fatta di apriorismi e ingiurie, deformazioni e repulse; se si aumenta ogni giorno più la disparità economica tra chi spedisce lingotti d’oro all’estero e chi vive nelle baracche e intristisce nella disoccupazione; se si insiste a vedere nel fratello insignito di un diverso distintivo politico un cane da abbattere, un rivale da sopprimere, un nemico da odiare?
Quanti cristiani, per assicurarsi un diritto all’odio, si tramutano in farisei che non vedono fratelli, ma pubblicani, ma samaritani, ma pagani. Come se Gesù non fosse mai venuto e non fosse morto e risorto!…
Quando si tratta di guerra, pare che non ci sia più niente di criminale: tutto viene verbalmente giustificato dalle necessità della guerra.
La scusa di evitarla tenta di giustificarne la preparazione; la vittoria da raggiungersi ad ogni costo fa lecito l’illecito. Mai come in tempo di guerra e per la guerra Machiavelli fa scuola.
Se qualcuno protesta, protesta contro la parte avversaria, la quale ha il torto di fare ciò che tutti fanno.
Quindi, più che una revisione di mezzi, o un controllo sugli armamenti (ciò che uccide, fosse anche un sasso, è sempre un mezzo cattivo) s’impone il controllo di noi stessi. Siamo così poco sicuri di volere veramente la pace, che ci teniamo offesi appena uno osa guardare dietro le nostre parole.
Proposte e controproposte di disarmo si rincorrono da anni; ma neppure l’uovo del controllo viene fuori, perché a Washington, a Londra, a Mosca, a Parigi, son tutte galline senza uova.
Per queste vie, che per colmo d’ironia si chiamano concrete (per certa gente, la concretezza è lo svenarsi nel riarmo prima e nei campi di battaglia poi), non si fa molto cammino verso la pace.
Non tengono né tre né cinque punti, né tre né cinque grandi, né conferenze a basso o alto livello, se prima non abbiamo il coraggio di spaccarci il cuore per scoprirvi il peccato in ogni pensiero di odio, e in ogni mano fratricida che per qualsiasi pretesto e con qualsiasi mezzo si leva contro l’uomo.
La guerra non è soltanto una calamità, ma un peccato. Se non avremo paura di afferrare il senso del peccato che c’è in ogni guerra, e di dichiarare le nostre contraddizioni di cristiani rispetto alla guerra, l’amore vincerà la pace.
Il tedesco Max Josef Metzger, « prete e martire » (com’è chiamato da un biografo protestante), fu ucciso dai nazisti nel 1944 perché predicava la pace.
Affermava: «Noi dobbiamo organizzare la pace, così come altri organizza la guerra».
In una lettera scritta dal carcere al papa nel 1944 asserì: «Se l’intera cristianità avesse fatto una potente, unica protesta, non si sarebbe evitato il disastro?».
Il cristiano che non si scopre in contraddizione col Vangelo di pace, o non si è mai guardato in Colui che — essendo «segno di contraddizione» — svela i pensieri degli uomini, oppure ama ingannare se stesso.
La misura della nostra elevazione spirituale viene fornita dalla maggiore o minore consapevolezza delle nostre contraddizioni, la quale ci distoglie dal sentirci soddisfatti e dal legare lo Spirito al nostro corto passo e ai nostri brevi traguardi.
Non è forse una contraddizione che dopo venti secoli di Vangelo gli anni di guerra siano più frequenti degli anni di pace?
che sia tuttora valida la regola pagana: «si vis pacem, para bellum»?
che l’omicida comune sia al bando come assassino, mentre chi, guerreggiando, stermina genti e città sia in onore come un eroe?
che nel figlio dell’uomo, riscattato a caro prezzo dal Figlio di Dio, si scorga unicamente e si colpisca senza pietà il concetto di nemico per motivi di nazione, di razza, di religione, di classe?
che l’orrore cristiano del sangue fraterno si fermi davanti a una legittima dichiarazione di guerra da parte di una legittima autorità?
che una guerra possa portare il nome di «giusta» o di «santa», e che tale nome convenga alla stessa guerra combattuta dall’un campo o dall’altro per opposte ragioni?
che si invochi il nome di Dio per conseguire una vittoria pagata con la vita di milioni di figli di Dio?
che venga bollato come disertore e punito come traditore chi, ripugnandogli in coscienza il mestiere delle armi, che è il mestiere dell’uccidere, si rifiuta al «dovere»?
che sia fatto tacere colui, che per sé soltanto, senza la pretesa di coniare una regola per gli altri, dichiara di sentire come peccato anche l’uccidere in guerra?
che si dica di volere la pace, e poi non ci si accordi sul modo, appena sopraggiunge il dubbio che ne scapiti la potenza, l’orgoglio, l’onore, gli interessi della nazione?
che si predichi di porre la vita eterna al disopra di ogni cosa, e poi ci si dimentichi che il cristiano è l’uomo che non ha bisogno di riuscire quaggiù?
Crediamo che questi pochi accenni bastino per dar rilievo alla nostra sostanziale contraddizione, per metterci in vergogna davanti a noi stessi, e per sentirci meno sicuri in un argomento ove la nostra troppa sicurezza potrebbe degenerare in temerarietà o in un delittuoso conformismo alle opinioni dominanti.
Cristianamente e logicamente la guerra non si regge. Cristianamente, perché Dio ha comandato: «Tu non uccidere» (e «Tu non uccidere», per quanto ci si arzigogoli sopra, vuol dire: «Tu non uccidere»); e per di più si uccidono fratelli, figli di Dio, redenti dal sangue di Cristo; sì che l’uccisione dell’uomo è a un tempo omicidio perché uccide l’uomo; suicidio perché svena quel corpo sociale, se non pure quel corpo mistico, di cui l’uccisore stesso è parte; e deicidio perché uccide con una sorta di «esecuzione di effigie» l’immagine e la somiglianza di Dio, l’equivalenza del sangue di Cristo, la partecipazione, per la grazia, della divinità.
L’antica profezia, che prepara il Vangelo, raccoglie e potenzia un’ansia di pace. Il più puro messianismo ebraico, come quello ellenico di Teocrito e quello romano di Virgilio, preannunzia un ordine nuovo in cui regneranno giustizia e pace per tutti e ci sarà pane per i poveri.
«Opus justitiae pax!». Così realisticamente la pace è vista dal profeta Isaia (32,17), non come un sogno narcissico, ma come un prodotto della giustizia. Il Messia sarà il pacificatore, colui che sopprimerà il muro di divisione tra il popolo eletto e i popoli reprobi, il riconciliatore. «E sarà chiamato col nome di principe della pace: il suo impero crescerà, e la pace non avrà più fine» (9,6).
E Michea precisa: «Egli sarà arbitro tra molti popoli, e imporrà leggi a potenti e remote nazioni. E trasformeranno le loro spade in vomeri, e le loro aste in zappe; e non impugneranno più, popolo contro popolo, le armi, e non si addestreranno più a maneggiare le armi» (4,3).
Con questa visione e con queste aspirazioni, i profeti chiedono al Signore: «Disperdi le nazioni che vogliono la guerra» (Salmo 67).
E Cristo venne: e sulla sua culla, nella notte dei tempi, gli angeli cantarono: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini». Quel che è la gloria per Dio in cielo, è la pace per gli uomini in terra: la pace è la gloria degli uomini; la gloria è la pace di Dio.
«Cristo è la nostra pace…», venuto «a recare il buon annunzio di pace», dice san Paolo ai romani, gente di guerra. La sua rivoluzione è la scoperta del fratello, fatta con la carità; e frutto della carità è la pace. La sua legge è il perdono: e il perdono tronca gli impulsi di guerra. La guerra denuncia, in chi la promuove, un ateismo effettivo, una ribellione a Dio.
Una delle beatitudini evangeliche suona: «Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio». I pacifici sono i facitori di pace: ché la pace si fa, si produce. Il cristiano è un produttore di pace, che ricostruisce indefinitamente nel tessuto dei secoli: e cioè ricostituisce senza tregua la vita, facendo «guerra alla guerra» come dice Pio XII, per combattere il suo nemico, che è la morte. I facitori di pace saranno figli di Dio. I facitori
di guerra saranno figli di Satana, che le Scritture chiamano «omicida».
Dove vale il Vangelo, regna la pace, negli individui e nelle nazioni; dove si scatena la guerra, il Vangelo è violato, anche se teologi pavidi o ingenui o prezzolati abbiano sfigurato talora le parole di Cristo per legittimare il carnaio.
Il cristiano è un «uomo di pace», non un «uomo in pace»; fare la pace è la sua vocazione.
Ogni vocazione è un seme, e il seme può «cadere lungo la strada, tra le spine, in luoghi sassosi o in un buon terreno». Poiché la strada, la pietraia, la brughiera non lo rifiutano, in ognuno di noi, indipendentemente dalla nostra fruttuosità, c’è una «pace seminale», la quale può aprirsi un varco attraverso qualsiasi resistenza.
E allora, anche se i miei piedi non si muovono verso la pace, sono un «uomo di pace»: anche se pecco contro la pace, fino a quando non rifiuto il Vangelo di pace, la pace è in agonia dentro di me.
La cristianità, nonostante le contraddizioni che la travagliano, e di cui tenta invano una giustificazione razionale, è un mondo che «agonizza per la pace».
La nostra fiducia — la parte umana della nostra fiducia — si nutre di questa paradossale condizione, che rivela l’aspetto militante della nostra vocazione di pace e il suo durissimo costo, poiché il dono è continuamente esposto alle vicissitudini dei tempi e alle incontinenze della nostra fragilità.
Il dialogo tra la pace e l’uomo — ora strada, ora pietraia, ora brughiera — dura da secoli sotto lo sguardo paziente della Chiesa che custodisce il Vangelo di pace e lo semina ovunque, senza chiedersi dove e come e se nascerà, poiché la sua missione non è di capire, molto meno di far trionfare la Parola, che ella deve solo custodire e seminare.
Chi onestamente considera l’impegno della Chiesa, invece di farle colpa se il mondo non è ancora un mondo pacifico, si meraviglia come il mondo non sia ancora riuscito a chiudere la bocca e a inchiodare le mani della instancabile seminatrice, e si sia limitato finora, fuori e dentro la cristianità, a congegnare ragionevoli scuse e dotte favole per dimostrare che conviene rimandare a tempi più maturi il comandamento della pace.
Il quale è tuttora in mora per non recar nocumento a quei brevi e piccoli interessi che ci sembrano più importanti della pace.
La pace cristiana è quindi ancora una pace crocifissa: e le ragioni che si adducono per tenerla inchiodata sono altrettanto valide di quelle tirate fuori nel sinedrio e nel pretorio per inchiodare il Pacifico.
Pare a molti che, invece di servirci della ragione per arrivare alla pace (le scuse degli invitati al banchetto non sono del tutto insensate), la sospendiamo, per timore che la pace faccia saltare il mondo dei nostri interessi.
Finora la pace ha trovato sulla sua strada più moderatori che cultori, più paura che fiducia: la paura di morire, non di far morire.
Molti, invece di considerarla un crimine, poiché facendo la guerra si uccide, la tengono come una disgrazia, per il fatto che in guerra si può essere uccisi.
Quando si parla di pace bisogna parlarne come ne parlano i fanciulli, non pensando a nient’altro, non negando con le mani o col cuore ciò che le labbra dicono.
La pace è un bene pieno: sulla pace non si ragiona né si distingue. È una parola che non sopporta aggiunte: una parola cristiana.
Da quando i cristiani si sono messi a « ragionare » sulla pace, a porre delle condizioni « ragionevoli » alla pace, a mettere davanti le loro « giustizie », non ci siamo più capiti, neanche in cristianità, ed è stata la guerra. Tutto il mondo ha «ragione» o crede d’averla. La «ragione» va con tutti, e finirà di stare col lupo, non con la pecora, la sola che avrebbe veramente ragione, se non invidiasse il lupo e non cercasse di superarlo.
La pace vuole un linguaggio semplice, senza riguardi di persone, senza retorica, senza crociate.
«Pace a voi!»
«Sia pace a questa casa!»
«Vi do la mia pace!»
«Rimanete nella mia pace!»
E si mettevano sulla strada, a due a due, senza borsa, senza bastone, senza niente. La gente li scherniva, quasi fossero dei pazzi; qualcuno però si fermava, mormorando: E se avessero ragione?
Ma dietro non avevano nessuno e niente. Non erano attaccati a nessuno, a niente: essi erano attaccati all’uomo, alla sua anima, alle sue tribolazioni, poiché l’uomo era entrato nel loro cuore assieme al Figlio dell’uomo, col nome di fratello.
Così è incominciato il Vangelo di pace.
Dicono:
l’uomo può perdonare: il cittadino non può perdonare;
il cristiano deve perdonare: la società non deve perdonare;
la Chiesa deve perdonare: lo Stato non deve perdonare.
E gli aforismi della saggezza corrente potrebbero riempire varie pagine…
Non ci si accorge che se uno soltanto non perdona, è come se nessuno perdonasse?
Il peccato di uno ha inquinato il mondo. Chi sono poi coloro che non devono perdonare?
Non sono uomini, ma concetti, cioè mostruosità fabbricate dall’uomo per non ascoltare l’uomo.
Moloch ha figliato: nazione, stato, classe, razza, democrazia, grandezza, onore, potenza, prestigio, gloria, libertà, giustizia: sono i suoi figli di oggi, che l’aiutano a divorare l’uomo.
Ma la patria — dicono — non è un interesse; la libertà non è un interesse; la democrazia non è un interesse; ma «valori spirituali».
Non lo neghiamo; ma se un bene spirituale viene tradotto in termini di interesse, per questi o per quelli, si può pretendere che altri vi si immoli come sopra un altare?
Dopo essere stati più volte ingannati nel corso di una stessa generazione, i poveri marciano riluttanti alla difesa di certi beni spirituali, che dovrebbero essere difesi, se veramente fossero sentiti come beni spirituali, sul piano dello spirito e con metodo adeguato.
Se invece di disporci a fare la guerra per salvare il nostro «patrimonio spirituale», si cercasse di renderlo un bene comune, radicandolo profondamente nell’animo di ognuno, chi ce lo potrebbe strappare?
Il diacono san Lorenzo, distribuendo ai poveri di Roma il patrimonio della Chiesa agognato dall’imperatore, ha trovato la vera maniera di salvarlo.
Per avere l’assenso di una testa, si può anche spaccarla o tagliarla: ma spaccandola o tagliandola non si guadagna l’assenso, si elimina un contraddittore. Dopo, però, ci si accorge che ha ragione la testa spaccata o tagliata, anche se prima aveva torto.
La testa di san Giovanni Battista ha più ragione sul piatto che sul collo.